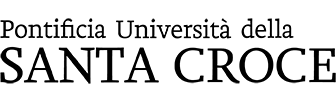Il Cardinale Raniero Cantalamessa ha preso possesso della Diaconia di Sant'Apollinare, Cappellania dell'Università

Domenica 13 giugno 2021 si è svolta la cerimonia di presa di possesso della Diaconia di Sant’Apollinare alle Terme Neroniane-Alessandrine - sede della Cappellania della nostra Università - del Cardinale Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., Predicatore della Casa Pontificia.
P. Raniero Card. Cantalamessa, ofmcap.
OMELIA PER LA XI DOMENICA DELL’ANNO B
In occasione della presa di possesso della diaconia di Sant’Apollinare alle Terme
Roma, 13 Giugno 2021
Vorrei, come prima cosa, ringraziare - anche in questa sede - il Santo Padre, papa Francesco, per avermi creato cardinale nel concistoro del Novembre scorso e per avermi assegnato come diaconia questa gloriosa e antica basilica di Sant’Apollinare alle Terme.
Ringrazio il vicario ausiliare della prelatura, Mons. Mariano Fazio e attraverso lui la grande famiglia dell’Opus Dei per la benevolenza con cui ha accolto la decisione del Santo Padre. Un grazie particolare al rettore della basilica, don Antonio Rodriguez de Rivera per la pazienza con cui ha seguito l’iter di questa presa di possesso più volte rinviata per la pandemia. A lui oggi facciamo anche gli auguri di Buon Onomastico.
Ringrazio il cerimoniere pontificio Mons. Lubomir Welnitz, per essermi al fianco in questa veste nuova e, credo, unica nella mia vita (almeno per quanto riguarda la mitra e il pastorale!). Grazie, infine, a tutti voi - confratelli e amici - che mi onorate della vostra presenza.
* * *
Passo ora al mio compito principale come presidente di questa celebrazione che è di commentare la parola di Dio. Un tema che ha sempre appassionato gli storici del cristianesimo è quello delle cause del suo rapido trionfo nel mondo antico. Un messaggio nato in un oscuro e disprezzato angolo dell’impero romano, tra persone semplici, senza cultura e senza potere, in appena tre secoli si estende a tutto il mondo allora conosciuto, soggiogando la raffinatissima cultura dei Greci e la potenza imperiale di Roma!
Qualcuno addita - come ragione del successo - l’amore cristiano, cioè l’esercizio attivo della carità verso i poveri, i carcerati, i malati. Si adduce, a riprova di ciò, il fatto che l’imperatore Giuliano l’Apostata, per contrastare la diffusione del cristianesimo, cercò di dotare il paganesimo di analoghe opere caritative. Uno dei più noti storici del cristianesimo antico vede la ragione del successo nella capacità della fede cristiana di conciliare in sé le opposte tendenze e i diversi valori presenti nelle religioni e nella cultura del tempo.
La religione cristiana – scrive - fin dal principio si affacciò con una universalità che le permise di avocare a sé tutta intera la vita, con tutte le sue funzioni, le sue altezze e profondità, sentimenti, pensieri ed azioni. Fu questo spirito di universalità che le assicurò la vittoria. Così s’illumina di nuova luce e appare quasi una necessità anche quella potente attrazione per cui essa giunse ad assorbire e a subordinare a sé l’Ellenismo” (A. von Harnack, Missione e propagazione del cristianesimo nei primi tre secoli).
L’impressione che si ha nel leggere queste ricostruzioni è che il successo del cristianesimo sia dovuto a un insieme di fattori esterni, di ordine sociale e culturale. Non si tiene conto (né, d’altronde, lo si potrebbe fare in quanto storici) che Gesù aveva dato lui stesso, in anticipo, una spiegazione del diffondersi del suo Vangelo. Tale spiegazione è contenuta nelle due parabole che abbiamo appena ascoltate nel vangelo. Essendo brevissime, possiamo riascoltarle per intero, cominciando dalla prima:
In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: «Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul terreno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la mietitura». (Mc 4,26-29).
Questa parabola, da sola, ci dice che la ragione essenziale del successo della missione cristiana non viene dall’esterno, ma dall’interno; non è opera del seminatore e neppure principalmente del terreno, ma del seme. Il seme non può gettarsi da se stesso, ha bisogno di un seminatore, tuttavia è per forza propria che germoglia e cresce. Dopo aver gettato il seme, il seminatore può anche andare a dormire; la vita del seme non dipende più da lui.
Chi ha colto con maggiore lucidità questo segreto è l’apostolo Paolo. «Io – dice – ho piantato, Apollo ha irrigato, ma è Dio che ha fatto crescere». Non si tratta di tre operazioni della stessa importanza; l’apostolo aggiunge infatti: «Ora, né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma chi fa crescere, e cioè Dio» (1Cor 3,6-7). Questa differenza qualitativa tra colui che semina e quello che viene seminato è espressa altrove dall’Apostolo con le parole: «Questo tesoro lo abbiamo in vasi di terra, affinché appaia che questa potenza straordinaria proviene da Dio e non da noi» (2Cor 4,7).
Passiamo alla seconda parabola.
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». (Mc 4,30-32).
Nel vangelo di Giovanni, Gesù spiega che questo seme caduto in terra, morto e risorto, altri non è che lui stesso (Gv 12, 24). L’insegnamento che Gesù ci dà con questa seconda parabola è dunque che il suo Vangelo e la sua persona sono quanto di più piccolo esista sulla terra, perché non c’è nulla di più piccolo e di più debole di una vita che finisce in una morte, e una morte di croce.
Eppure questo «granello di senapa» è destinato a diventare un albero gigantesco, tanto da accogliere tra i suoi rami tutti i popoli della terra. Che contrasto rispetto alle ricostruzioni degli storici! Lì tutto sembrava incerto, aleatorio, aperto sia al successo che al fallimento; qui tutto era già deciso e assicurato dall’inizio!
«Ogni albero – dice Gesù – si riconosce dal suo frutto» (Lc 6,44). Questo vale per ogni albero, eccettuato l’albero nato da lui, cioè il cristianesimo. Quest’unico albero, meglio che dai frutti, si conosce dal seme e dalla radice! Nel cristianesimo, in altre parole, la pienezza e la perfezione non sono alla fine, ma al principio. Nessun frutto - neppure quello rappresentato dai più grandi santi, martiri, mistici e dottori della Chiesa - aggiunge qualcosa alla perfezione del modello. In questo senso ha ragione il filosofo Kierkegaard quando afferma che «il cristianesimo non è perfettibile» (Diario, X5 A 98).
Già a suo tempo l’evangelista Giovanni denunciava coloro che pretendevano di andare “oltre Cristo”: “Chi va oltre –scriveva - e non rimane nella dottrina del Cristo, non possiede Dio” (2 Gv v. 9). Questo proposito degli gnostici del tempo di andare “oltre” Cristo è tuttora presente in molti ambiti della cultura: filosofia, teologia, scienza, letteratura. Consiste nel tentativo di includere Cristo in un panorama religioso più vasto, in cui egli non è più il tutto, il Pleroma, l’Alfa e l’Omega della storia, ma è parte di un universo più grande; una delle grandi parole risuonate nella storia umana, non “la Parola” tout court, uno dei saggi dell’umanità, non il Figlio di Dio venuto in questo mondo.
* * *
I primi cristiani avevano una ferma certezza della vittoria finale della loro causa. «Voi potete ucciderci, ma non potete nuocerci», diceva il martire Giustino rivolgendosi all’imperatore romano. Alla fine, fu questa tranquilla certezza che convinse le autorità politiche dell’inutilità degli sforzi per sopprimere la fede cristiana.
È questo ciò che più ci occorre oggi: ridestare nei cristiani la certezza intima della verità di quello che annunciano. «La Chiesa – ha detto una volta il papa san Paolo VI – ha bisogno di riacquistare l’ansia, il gusto e la certezza della sua verità» (Udienza generale del 29 novembre 1972). Dobbiamo credere, noi per primi, in ciò che annunciamo; ma crederlo veramente, con tutto il nostro essere, mente e cuore. La fede – come, in senso negativo, la pandemia - si diffonde per contagio, non per averne sentito parlare.
Dobbiamo scrollarci di dosso ogni senso di impotenza e di rassegnazione. Il mondo intorno a noi ragiona come abbiamo sentito che hanno sempre ragionato gli storici che si sono occupati della diffusione del cristianesimo. La differenza è che, anziché concludere a favore dell’inevitabile trionfo del cristianesimo, oggi si conclude a favore dell’inevitabile fine di esso e di ogni religione. Sono profezie che si ripetono da almeno tre secoli con stupefacente regolarità e disarmante noncuranza di ogni smentita dei fatti. “La Chiesa è a un punto morto”, “la Chiesa è agli sgoccioli”: sono titoli dei notiziari di questi giorni.
L’errore è sempre lo stesso: si tiene conto del seminatore umano e non del seme, della Chiesa istituzione, non di Cristo risorto e vivente nella Chiesa. In una delle prediche alla Casa Pontificia della Quaresima di quest’anno ho svolto questa riflessione. Il pensiero moderno illuminista nasce all’insegna della massima: vivere “etsi Deus non daretur”, vivere come se Dio non esistesse. Il pastore Dietrich Bonhoeffer ha tentato di dare, di questa massima, una interpretazione accettabile anche dai cristiani. Il suo tentativo è stato giustamente contestato, ma dobbiamo renderci conto che lo stesso pericolo è presente sotto altra forma, non meno insidiosa, e consiste nel vivere “etsi Christus non daretur”, come se Cristo non esistesse.
E’ il presupposto con cui il mondo e i suoi mezzi di comunicazione parlano tutto il tempo della Chiesa. Di essa interessano la storia (quella negativa, non certo quella della santità), l’organizzazione, il punto di vista sui problemi del momento, i fatti e i pettegolezzi interni ad essa. Fateci caso: nei mezzi di comunicazioni sociale, a stento si trova nominata una volta la persona di Gesú quando si parla della Chiesa.
Nella preoccupazione - per altro, giustissima - di rispondere alle esigenze e alle provocazioni della storia e della cultura, corriamo il pericolo mortale di comportarci, anche noi credenti, “etsi Christus non daretur”, come se si potesse parlare della Chiesa prescindendo da lui e dal suo Vangelo. La risposta a questa sfida non deve essere solo di natura apologetica, ma prima di tutto spirituale. In altre parole, non parlare per convincere gli altri che Gesú Cristo è il Signore, ma fare sì che egli divenga sempre più realmente il Signore della nostra vita, la nostra luce e la nostra gioia.
* * *
Nella parabola Gesù ci ha parlato di un seminatore che getta il seme e poi se ne va tranquillo a dormire. Così fece lui nella sua vita. Seminò la parola, la affidò alla memoria di alcuni poveri pescatori; poi, venuta l’ora, andò alla croce, senza aspettare di vedere i frutti della sua opera. Sapeva bene chi si sarebbe incaricato di spiegarla e mantenerla viva nei secoli: lo Spirito Santo, il Paraclito!
È ciò che ho voluto ricordare a me stesso e ai miei fratelli di fede, scegliendo l’immagine della colomba e il motto “Veni Creator Spiritus” per il mio stemma cardinalizio, ora esposto sulla facciata di questa basilica. Anch’io ho gettato tanti semi in giro per il mondo, al servizio dell’unico grande Seminatore. Si avvicina il momento anche per me di andare a “dormire”; ma sono sereno: c’è chi penserà a far crescere i semi gettati.
Di quel seme vivente caduto in terra, morto e risorto, abbiamo nutrito fin qui la nostra mente attraverso la Parola; ora nutriremo di esso anima e corpo con l’Eucaristia. Egli ripete a noi quello che disse ai suoi apostoli prima di lasciare la terra: “Abbiate fiducia: io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33).